
Questo il tema dell’Almanacco Pontremolese 2025: dagli erbari all’uso in cucina, dalla storia al folklore locale
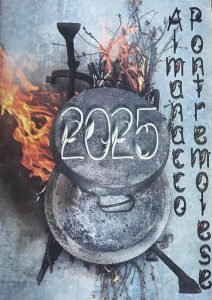 E’ stato presentato domenica 22 dicembre nel palazzo del Tribunale in piazza della Repubblica, l’Almanacco Pontremolese 2025, pubblicazione giunta alla sua 47^ edizione, quest’anno dedicata al tema delle ‘erbe’, raccontate nelle molteplici funzioni e nel loro indissolubile legame con il territorio.
E’ stato presentato domenica 22 dicembre nel palazzo del Tribunale in piazza della Repubblica, l’Almanacco Pontremolese 2025, pubblicazione giunta alla sua 47^ edizione, quest’anno dedicata al tema delle ‘erbe’, raccontate nelle molteplici funzioni e nel loro indissolubile legame con il territorio.
Una sorta di esplorazione del mondo vegetale della Lunigiana attraverso la storia, le tradizioni del territorio e l’interpretazione dell’ambiente naturale che lo compone. Ed allora i profumi, i colori, i sapori, i segreti delle erbe accompagnano nella lettura dell’Almanacco. In particolare “protagonista” di questa edizione dell’Almanacco è il progetto di restauro conservativo dell’erbario “Hortus siccus – De Briganti – Siccus”.
A raccontare la genesi di questo progetto, nel suo articolo, è Antonella Bonvicini, presidente dell’associazione onlus “Cio nel cuore”. Tutto nasce, scrive la Bonvicini quando “tra i membri del consiglio direttivo nasce l’idea di valutare la possibilità di finanziare il restauro di una delle tante opere conservate nella splendida Biblioteca Antica” del Seminario Vescovile. Durante un incontro con la bibliotecaria e restauratrice Elisa Battilla ad attirare l’attenzione fu un libro decisamente particolare “una raccolta di erbe e piante essiccate proveniente dall’alta Lunigiana raccolte in un antico erbario”.
Si tratta dell’Hortus Siccus, “un antico erbario di epoca settecentesca giunto alla Biblioteca del Seminario intorno al 1970”. Il minuzioso intervento conservativo, realizzato con cura, passione e professionalità, si conclude a fine 2024 con il sopralluogo da parte della Soprintendenza.
 Sempre sul “Hortus siccus” è anche incentrato l’intervento di don Emanuele Borserini, responsabile dei beni culturali della diocesi di Massa Carrara, il quale ha ripercorso la delicata fase del restauro dell’antico testo ed ha anche evidenziato ora come la Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli “può dare inizio alla seconda fase della sua valorizzazione e conservazione” un cammino non semplice con lo scopo “di perpetuare la memoria storica del territorio ma anche di dotare questa memoria di un nuovo linguaggio comunicativo”.
Sempre sul “Hortus siccus” è anche incentrato l’intervento di don Emanuele Borserini, responsabile dei beni culturali della diocesi di Massa Carrara, il quale ha ripercorso la delicata fase del restauro dell’antico testo ed ha anche evidenziato ora come la Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli “può dare inizio alla seconda fase della sua valorizzazione e conservazione” un cammino non semplice con lo scopo “di perpetuare la memoria storica del territorio ma anche di dotare questa memoria di un nuovo linguaggio comunicativo”.
Il fatto che gli erbari siano i protagonisti di questa edizione dell’Almanacco lo dimostra anche l’articolo di Giuseppe Benelli su “Gli erbari di piante disseccate della Lunigiana”. Benelli sottolinea come fino agli inizi dell’800 gli erbari hanno esclusivamente carattere personale “ogni studioso forma il suo erbario o come mezzo necessario per i suoi studi o come mezzo di riconoscimento delle piante medicinali”.

In Lunigiana si conserva presso la Biblioteca Civica di Fivizzano un erbario attribuibile al XVII secolo, in cui per ogni erbe c’è un testo medico con le proprietà terapeutiche dei campioni botanici. Poi Benelli ha voluto in particolare ricordare la figura di varie botanici lunigianesi, tra cui Erminio Ferrarini, studioso, in particolare, della flora e della vegetazione delle Alpi Apuane e dell’Appennino.
Ovviamente le erbe in Lunigiana richiamano anche ad uno degli alimenti simbolo del territorio, ovvero la torta d’erbi. Ne parla Natalino Benacci ne “Al mister dla turta d’erbi” che nel raccontare questo piatto (“davvero povero ma dal gusto straordinario”) ricorda come le prime notizie di torte in Lunigiana siano contenuta già nelle memorie di Giovanni Antonio Da Faie (1443) “già a quei tempi le torte cucinate con ingredienti di campo rappresentavano il lato b dell’alimentazione quotidiana nei mesi delle belle stagioni” terminato il periodo dei cibi legati alla castagna.
Benacci ha poi ricordato la figura di Alberto Bellotti che ha omaggiato la torta d’erbi sia nella cura della preparazione che con versi in dialetto pontremolese.
Sempre dedicata alla torta d’erbi il racconto di Andrea Benelli legato alla “Mitica torta d’erbi dell’Assunta”. Restando in ambito alimentare, Luciano Bertocchi racconta di “Quando la dieta era un’imposizione e non una scelta”. Ovvero di quando le donne di casa nel periodo primaverile andavano per i prati del territorio a caccia delle erbe commestibili. Per chi volesse realizzare qualche piatto ci sono anche le ricette con le erbe dell’Alberghiero (anche se bisogna davvero aguzzare la vista per riuscire a leggerle!).
Ma non solo cibo, con le erbe si possono realizzare anche liquori e amari. Come il caso de “L’acqua del castello di Grondola” di cui parlano Angela Bergamaschi e Maria Rita Franchi. Un liquore ideato da don Luigi Castellotti che nel 1892 “miscelando con cura ingredienti segreti, distillò un liquore dall’azione a suo dire ammirabile e sorprendente”.
Il liquore incontrò il favore del pubblico e ottenne premi e menzioni.
Il primo articolo di Rossana Piccioli si incentra sulle piante esotiche presenti nel paesaggio lunigianesi mentre il secondo si sofferma sulla “Botanica e folklore in Lunigiana” quindi sulle proprietà terapeutiche delle piante ma anche al loro aspetto simbolico, con aspetti legati alla tradizione. Ritornando, infine, alla storia Paolo Lapi propone un viaggio su come gli Statuti dei vari comuni della Lunigiana regolassero la raccolta delle erbe nel territorio.
(Riccardo Sordi)


