
I romanzi di Ettore Schmitz (noto con lo pseudonimo Italo Svevo), l’irredentismo di Scipio Slataper e di Gianni Stuparich

A partire da fine Ottocento Trieste fu un vivace centro culturale ed artistico. Eugenio Montale definì la città come essa stessa “personaggio” nei romanzi di Ettore Schmitz, noto con lo pseudonimo Italo Svevo, un nome che designa la formazione mitteleuropea dello scrittore che studia in Baviera e che si incontra con la cultura italiana, scrivendo in un italiano con “sgrammaticature” perché lingua per lui frutto di “un faticoso acquisto”.
Svevo coglie al meglio il travaglio di un’epoca che con Sigmund Freud scopre e analizza la dimensione subconscia e inconscia dell’Io. Una malattia dell’anima rende i protagonisti dei tre romanzi sveviani “ignari e inetti”, incapaci di raggiungere progetti di vita.

Prima dei turbamenti esistenziali dei giovani protagonisti della trilogia di Svevo, la città giuliana fu centro ispiratore di una letteratura irredentista, di necessaria intonazione patriottica; la troviamo nelle opere di Scipio Slataper, autore di “Il mio Carso”, volontario in guerra, morto sul Podgora. Lo stesso irridentismo lo troviamo in Gianni Stuparich autore di “Diario di guerra”. Nella vicina Duino Eric Rilke portò i fermenti del circolo di Praga da lui condiviso con Franz Kafka.
In epoca asburgica Trieste è in rapporto con i fermenti culturali di Vienna e accoglie dal 1904 al 1915 l’irlandese James Joyce che con “Ulisse” rivoluzionò il romanzo del Novecento. Trieste è cantata in modo mirabile nel Canzoniere di Umberto Saba, ebreo da parte di madre, poeta solitario, ermetico.
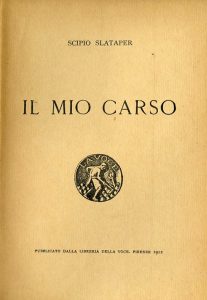 Con “parole senza storia” Saba canta la vita quotidiana, loda la moglie paragonandola alle “femmine di tutti i sereni animali che avvicinano a Dio” con rimembranze francescane. Passeggiando in città si incontra idealmente Saba nella sua libreria antiquaria, che fu costretto a lasciare per le leggi razziali. Come un novello Ulisse si sente ancora sospinto al largo da un “doloroso amore della vita”.
Con “parole senza storia” Saba canta la vita quotidiana, loda la moglie paragonandola alle “femmine di tutti i sereni animali che avvicinano a Dio” con rimembranze francescane. Passeggiando in città si incontra idealmente Saba nella sua libreria antiquaria, che fu costretto a lasciare per le leggi razziali. Come un novello Ulisse si sente ancora sospinto al largo da un “doloroso amore della vita”.
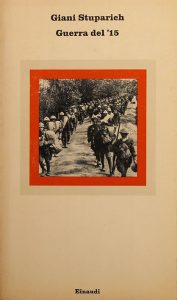 Canta Trieste che ha una “scontrosa grazia”, la contempla dall’erta collina “in ogni parte è viva”; va spesso in un’oscura via di città vecchia e incontra creature della vita e del dolore e in esse “si agita il Signore”, in compagnia degli umili “sente il suo pensiero farsi più puro”. La poesia di Saba dovremmo meditarla intensamente in questa nuova barbarie in cui siamo precipitati: che lo scrittore e giornalista triestino Paolo Rumiz descrive con rigore di analisi veritiera nel suo recentissimo saggio “Verranno di notte”.
Canta Trieste che ha una “scontrosa grazia”, la contempla dall’erta collina “in ogni parte è viva”; va spesso in un’oscura via di città vecchia e incontra creature della vita e del dolore e in esse “si agita il Signore”, in compagnia degli umili “sente il suo pensiero farsi più puro”. La poesia di Saba dovremmo meditarla intensamente in questa nuova barbarie in cui siamo precipitati: che lo scrittore e giornalista triestino Paolo Rumiz descrive con rigore di analisi veritiera nel suo recentissimo saggio “Verranno di notte”.
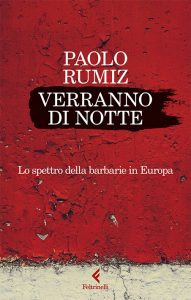 È poesia che grida che non si deve fomentare l’odio, non si deve uccidere la vita in innocenti tenere creature. Con la cultura maturata nella sua complessa storia Trieste ha spezzato le chiusure e le angustie del provincialismo, ha saputo mantenere una linea dialogante con le diversità, ha fatto esperienza tragica delle violenze ideologiche e delle tragedie nate da rivalse e vendette e ne ha capito le conseguenze gravi, quelle che nel territorio a lei frontaliero hanno di nuovo fatto versare sangue nelle guerre balcaniche e riempito le navi di migranti.
È poesia che grida che non si deve fomentare l’odio, non si deve uccidere la vita in innocenti tenere creature. Con la cultura maturata nella sua complessa storia Trieste ha spezzato le chiusure e le angustie del provincialismo, ha saputo mantenere una linea dialogante con le diversità, ha fatto esperienza tragica delle violenze ideologiche e delle tragedie nate da rivalse e vendette e ne ha capito le conseguenze gravi, quelle che nel territorio a lei frontaliero hanno di nuovo fatto versare sangue nelle guerre balcaniche e riempito le navi di migranti.
Per concludere. È stata fatta politica della diplomazia e del metodo del confronto democratico e si sono riaperti i confini. Dopo l’esilio famiglie smembrate si sono ricomposte per un’esistenza aperta al futuro, con chiara consapevolezza che la pace è la sola, vera energia di sviluppo.
Vivere la vita in questa visione, anche cogliendo l’occasione dell’anniversario del ritorno di Trieste all’Italia, è buona cosa e sarebbe bene che lo capissero ebrei, arabi e turchi e tanti altri, noi compresi. Questo ultimo discorso può essere preso come una predica fatta da vecchie professoresse che finiscono sempre col far lezione, ma siamo arrivati al punto che non si deve e non si può più stare zitti o indifferenti di fronte alle aberrazioni quotidiane che vengono da Oriente con etimo “là dove sorge il Sole”…
(mlsb)


