
L’ultima opera di Immanuel Kant. Nel breve saggio il filosofo dà indicazioni dettagliate per liberare dal dispotismo di uno o di pochi e realizzare la pace stabile. Per la pace perpetua ci vuole la costituzione repubblicana perché questa si basa sul principio di libertà dei membri di una società

L’ultima opera di Kant del 1795 mette al centro l’impegno del filosofo per la pace e la giustizia. Per poter operare su questa linea bisogna far uso della propria intelligenza e pensare con la propria testa.
Kant vive 80 anni nel “secolo dei lumi”, ne è esponente per il mondo germanico: alla domanda Cosa è l’Illuminismo? rispose in latino sàpere aude (osa essere saggio). Il complesso sistema filosofico kantiano, non riassumibile neppure in elementare sintesi, indica anche a noi profani che è la dignità morale dell’uomo, la sua libertà di pensiero, la diffusione delle idee a dare la felicità.
Per liberare dal dispotismo di uno o di pochi e realizzare la pace stabile il breve saggio dà indicazioni dettagliate.
Nella prima sezione indica i criteri preliminari per mettere pace fra gli Stati.
– il trattato di pace deve eliminare tutte le cause di guerra futura;
– non può uno Stato indipendente essere acquistato da un altro per eredità, scambio, acquisto o donazione;
– gli eserciti permanenti devono col tempo sparire completamente;
– lo Stato non accresca indefinitamente i debiti rendendo il denaro una temibile potenza con facilità a fare la guerra;
– nessuno deve ingerirsi a forza nel governo di un altro Stato.
Nessuno Stato in guerra deve permettersi atti contro l’avversario come assassinare, avvelenare, incitare al tradimento. La seconda sezione contiene articoli definitivi in vista della pace perpetua fra gli Stati. Lo stato di pace non è uno stato di natura, deve essere istituito, la pace non è solo assenza di guerra.

Per la pace perpetua ci vuole la costituzione repubblicana perché questa si basa sul principio di libertà dei membri di una società, tutti si riconoscono in un’unica comune legislazione e sulla legge dell’uguaglianza di tutti: senza la costituzione a repubblica non è mai stato possibile fare il “contratto sociale originario”.
Ci sono diritti innati inerenti all’uomo e sono inalienabili. Anche di fronte alle leggi divine, Kant, educato dalla madre fervente devota al pietismo, corrente luterana di cristiani rigorosi, dice di essere ad esse legato solo nella misura in cui ha potuto dare assenso nella sua libertà di farsi un concetto della volontà di Dio.
La repubblica ha anche il vantaggio di farci sperare nella pace perpetua perché richiede il consenso dei cittadini: prima di dichiarare una guerra [altro che “l’ora segnata dal destino” gridata da quel balcone!] uno ci pensa bene se vuole davvero un gioco così pericoloso. Il diritto dei popoli deve fondarsi su un ordinamento federativo di Stati liberi.
Se ragioniamo, abbiamo chiaro che la pace è un dovere immediato. Nel nostro presente di guerre e terrorismo lo stesso imperativo categorico kantiano lo grida in solitudine e con dolore papa Francesco.
Ci sono i diritti cosmopolitici e devono favorire una ospitalità universale. Dato che la terra è sferica, non si estende all’infinito, dobbiamo vivere uno accanto agli altri e rispettare il diritto di ospitalità, di allacciare commerci e rapporti pacifici tra parti del mondo anche fra loro lontane avvicinando il genere umano a una costituzione cosmopolitica. [Ci sarebbe l’ONU!]
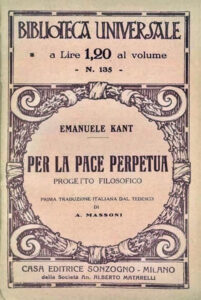 Kant aggiunge due supplementi di garanzia della pace perpetua. Quella che chiamiamo provvidenza è la profonda, nascosta saggezza rivolta al bene oggettivo del genere umano e sa predeterminare le cose.
Kant aggiunge due supplementi di garanzia della pace perpetua. Quella che chiamiamo provvidenza è la profonda, nascosta saggezza rivolta al bene oggettivo del genere umano e sa predeterminare le cose.
La garanzia viene dalla natura che fa emergere, anche contro la loro volontà, l’armonia dalla discordia tra gli uomini. I filosofi suggeriscono le condizioni che rendono possibile la pace perpetua, i governi sapienti li ascoltano in segreto e mettono in atto i loro consigli. Non si sbaglia quando si dice che le soluzioni dei problemi sono di matrice culturale!
In Appendice Kant osserva che non può esserci nessun dissenso tra morale e politica riguardo alla pace perpetua, però non si deve intendere per morale l’uso dei mezzi più adatti al solo interesse personale.
Cercare la giustizia è realizzare da se stessa la pace perpetua, in conformità anche al diritto pubblico nelle varie relazioni tra Stati e società. Quanto è qui scritto riporta in sintesi il libro di Kant con le sue stesse parole, letto tutto con attenzione analitica.
Può essere di pesante lettura ma dice cose così belle, vere e attuali, pensate con fiducia e realismo da un gigante del pensiero dell’Occidente.
(M.L.S.)


