
Portò il romanzo dell’Ottocento alla verità della storia e delle persone e rinnovò la lingua della narrativa. Verdi lo onorò componendo la Messa da Requiem

“Il santo Vero mai non tradir; né proferir mai verbo che plauda al vizio, o la virtù derida” gli aveva insegnato Carlo Imbonati, amante della madre, la bella Giulia figlia del grande Cesare Beccaria; e Manzoni crea poesia meditando su eventi storici: lo fa negli Inni sacri, le Odi civili, le tragedie e in modo supremo nel romanzo I Promessi sposi, il più grande romanzo storico della letteratura italiana.
Non ha nulla di romanzesco, di narrazione avventurosa falsificante la realtà; anzi il sottotitolo è “Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da A. Manzoni” e l’occasione sarebbe stato un dilavato e graffiato scartafaccio di un secentista anonimo che lui avrebbe solo trascritto in lingua moderna dei ben parlanti fiorentini.
Dominato dalla forma mista di storia e d’invenzione, il giudizio morale è sempre presente, ma nulla sa di oratoria, di volontà di persuasione. Il cattolico e liberale Manzoni, che ha scelto di farsi cristiano maturando una convinzione profonda che Dio aiuta e provvede, sa che i guai a volte li cerchiamo ma non li evita neppure la condotta più prudente, però la fiducia in Dio “li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore”, è questo “il sugo” di tutta la storia affidato a povera gente.
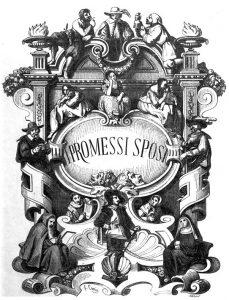 Non per teorie ma per fede vissuta si svolge la storia dei due fidanzati, popolani filatori di seta, che non avrebbero lasciato traccia di sé nella storia (che dà lustro solo ai potenti) se non si fossero imbattuti in quel puntiglio di don Rodrigo, piccolo boss mafioso, di avere Lucia.
Non per teorie ma per fede vissuta si svolge la storia dei due fidanzati, popolani filatori di seta, che non avrebbero lasciato traccia di sé nella storia (che dà lustro solo ai potenti) se non si fossero imbattuti in quel puntiglio di don Rodrigo, piccolo boss mafioso, di avere Lucia.
La novità del romanzo manzoniano è il capovolgimento di prospettiva: protagonisti sono persone semplici fedeli al Vangelo, che senza volerlo inciampano nelle trappole dei prepotenti. Manzoni, di formazione illuminista, si accorge che la ragione non basta a soddisfare tutte le esigenze dell’uomo, è Dio a sostenere i bisogni più veri e intimi.
La figura che riassume le doti del popolo è Renzo: generoso, vuole giustizia per istinto, ha una religiosità schietta, laborioso e sereno, sa dare amicizia, vive sentimenti freschi, senza opportunismi, rimane incastrato nelle insidie della città. Conduce una sottile polemica contro l’inefficacia delle “gride” che vietavano la scorta dei “bravi”, contro gli Azzeccagarbugli cortigiani, contro il latinorum di don Abbondio, egoistico esemplare del quieto vivere, in antitesi con la vita spesa ad aiutare gli altri di padre Cristoforo, un vero cristiano.
E poi c’è Lucia, gentile e riservata, una contadina in cui la fede in Dio infonde una luce ineffabile, e c’è la madre Agnese, premurosa, suggerisce soluzioni pragmatiche alla prepotenza subita: andar dall’avvocato, fare il matrimonio di sorpresa, falliscono e lei sa dire il perché al cardinal Federigo: “I poveri ci vuol poco a farli comparir birboni”, è la filosofia della casalinga che l’intellettuale è obbligato a riconoscere vera. (la porpora si inchina al grembiule commenta Luigi Russo).
Intorno ai due sposi gira la vita di un villaggio e tutto un mondo di oppressi dalle ingiustizie dei dominatori della politica che anche allora portavano fame, rivolte popolari, invasioni e la peste, che l’immutabile don Abbondio in metafora dice esser stata una scopa che ha portato via tanta brava gente ma anche certi soggetti freschi e prosperosi come don Rodrigo.
Entusiasmante del romanzo è la novità di un giudizio morale che dà tono, colore, sostanza religiosa e rivoluzionaria: le creazioni di fantasia riflettono i meccanismi psicologici, la storia di fatti in pienezza di verità. Scatta la pietà sulla monaca di Monza, colpevole e vittima di una civiltà pomposa e puntigliosa, insignificanti e incompetenti i politici, non mancano momenti di comicità senza cadere nella caricatura: Don Ferrante, donna Prassede ostinata nel fare il bene, il più degno mestiere, ma per farlo bisogna conoscerlo!
Il lettore, osservava Umberto Eco, vuole il lieto fine, che c’è nel romanzo che ebbe tre stesure, la provvidenza divina “la c’è, la c’è” toscaneggia Renzo quando da clandestino riesce a passare l’Adda e arriva a Bergamo, ma è raggiunta coi “travagli e le miserie, per disporvi a un’allegrezza raccolta e tranquilla” dice padre Cristoforo agli sposi finalmente ricongiunti, avranno figli e Renzo può diventare la metafora del piccolo imprenditore del Nord, in ascesa sociale.
(M.L.S.)


