
Erano le 7,50: la scossa del decimo grado della scala Mercalli con epicentro tra Fivizzano e Casola. Colpite anche la Garfagnana e la Versilia. Interi paesi distrutti, 171 i morti: più della metà erano bambini
 Una terra “ballerina”: così, mercoledì 8 settembre 1920, il quotidiano “La Nazione” dava la notizia del terremoto avvenuto a Fivizzano alle ore 7,50 del giorno precedente: “La Toscana settentrionale è stata devastata dal terremoto. Paesi della Garfagnana, della Lunigiana, della Versilia rasi al suolo o rovinati. I morti sono circa un centinaio. Danni gravi e feriti in altre località. Scene desolanti di morte e intere popolazioni accampate all’aperto”. A provocare questo disastro fu il terremoto più catastrofico della storia sismica della Lunigiana: scossa del X grado della scala Mercalli, 6,8 Richter, preceduta da una del VI del giorno 6 e seguita da molte altre.
Una terra “ballerina”: così, mercoledì 8 settembre 1920, il quotidiano “La Nazione” dava la notizia del terremoto avvenuto a Fivizzano alle ore 7,50 del giorno precedente: “La Toscana settentrionale è stata devastata dal terremoto. Paesi della Garfagnana, della Lunigiana, della Versilia rasi al suolo o rovinati. I morti sono circa un centinaio. Danni gravi e feriti in altre località. Scene desolanti di morte e intere popolazioni accampate all’aperto”. A provocare questo disastro fu il terremoto più catastrofico della storia sismica della Lunigiana: scossa del X grado della scala Mercalli, 6,8 Richter, preceduta da una del VI del giorno 6 e seguita da molte altre.
Dalle cronache del tempo veniamo a conoscenza dell’immane tragedia che colpì le popolazioni, in particolare, di Fivizzano, Vigneta, Villa Collemandina, individuata come epicentro del sisma. I morti furono 171, di cui 30 a Fivizzano. Si ritiene che molti, specialmente uomini, si salvarono perché già usciti di casa per andare al lavoro nei campi (più della metà delle vittime furono bambini). Il primo “a partire in cerca di soccorsi fu il brigadiere Ravasio della Caserma di Fivizzano, il quale, mentre la popolazione fuggiva disperata, senza meta, montava sopra ad un calesse precipitandosi nel vicino paese di Soliera, da dove poteva telegrafare a Massa, La Spezia, ad Aulla”.
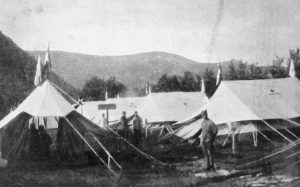 Nel giro di poco tempo, anche se alcuni lamentarono ritardi, giunsero in aiuto, oltre a numerosi volontari, pompieri e i marinai della Regia Nave Cavour dalla Spezia, Vigili del fuoco da Rimini , circa mille fanti da Bologna, Firenze , Piacenza. Quante le scene di dolore raccontate dai sopravvissuti o dai soccorritori! Nel Piazzone si raccolse il maggior numero di terremotati: “Tra loro gira – scriveva Giuseppe Rossi sul giornale citato – un giovane con gli occhi smarriti e la faccia sconvolta: è il povero Enzo Moratti; intorno a lui molta gente, perché la sua sciagura sembra la più terribile. In piazza Vittorio Emanuele il crollo di un edificio ha portato la morte nella famiglia Moratti, titolare dell’Ufficio postelegrafonico, uccidendo le sorelle Emma e Gina, il fratello Elisio, la cognata con i bimbi Beppe e Vittorino. Solo Enzo si salvò”.
Nel giro di poco tempo, anche se alcuni lamentarono ritardi, giunsero in aiuto, oltre a numerosi volontari, pompieri e i marinai della Regia Nave Cavour dalla Spezia, Vigili del fuoco da Rimini , circa mille fanti da Bologna, Firenze , Piacenza. Quante le scene di dolore raccontate dai sopravvissuti o dai soccorritori! Nel Piazzone si raccolse il maggior numero di terremotati: “Tra loro gira – scriveva Giuseppe Rossi sul giornale citato – un giovane con gli occhi smarriti e la faccia sconvolta: è il povero Enzo Moratti; intorno a lui molta gente, perché la sua sciagura sembra la più terribile. In piazza Vittorio Emanuele il crollo di un edificio ha portato la morte nella famiglia Moratti, titolare dell’Ufficio postelegrafonico, uccidendo le sorelle Emma e Gina, il fratello Elisio, la cognata con i bimbi Beppe e Vittorino. Solo Enzo si salvò”.
Straziante anche quanto avvenuto alla Porta di Sotto: “Le rovine di una casa hanno travolto e ucciso la giovane Maria Jacomelli, di 29 anni, incinta di 4 mesi, e i figli Maria e Gino”. Si registrarono morti anche fra i soccorritori: un carabiniere e due cittadini, mentre facevano ricerche fra le macerie, furono schiacciati dal crollo di un muro a seguito di una scossa.
I terremoti in Lunigiana:
da quello del 7 maggio 1481 a quello del 2013La pericolosità sismica di un luogo si ricava dalla sua storia. Gli esperti dicono che, dove si è verificato un grosso terremoto, c’è da attenderlo nuovamente, ma “come fenomeno naturale ricorrente, non periodico”. Quindi non può essere previsto, se non quando sarà possibile scoprirne le cause, sulle quali pare che oggi si siano fatti grandi progressi. Per ora la “prima difesa è la prevenzione, individuata nelle regole di costruzione, nei piani d’emergenza, nei comportamenti”.
Padre Dino Bravieri, che è stato direttore dell’Osservatorio Ximeniano di Firenze, in una lezione tenuta nel 1988 a operatori della protezione civile, fece un elenco dei terremoti lunigianesi, che parte dal sisma di Fivizzano del 7 maggio 1481. Certamente ne saranno avvenuti anche prima, ma non sono attestati da documentazione, quindi non citabili. Quel terremoto ( VI-VII grado) fece notevoli danni.
Il 9 giugno 1545 a Pontremoli ci fu una scossa dell’VIII grado. Nei giorni 8,9,10 giugno del 1641 molti edifici in Lunigiana subirono gravi danni. Molto forte ( IX Mercalli) fu il terremoto del 13 febbraio 1834 a Pontremoli, ma non si registrarono morti.
A Ugliancaldo, l’11 aprile 1837, caddero 93 delle cento case del paese, ma una sola rimase abitabile. Pauroso fu il terremoto del 10 settembre1878 a Fivizzano e a Soliera. Dopo la scossa distruttiva del 7 settembre 1920, è ricordato il sisma del 15 ottobre 1939 a Fivizzano (VII grado Mercalli).
Del VII grado fu anche quello del 25 ottobre 1952, tra Pontremoli e Borgotaro. L’ultimo terremoto è avvenuto il 21 giugno del 2013, ma uno piuttosto forte anche il 10 ottobre 1995. In entrambi, specialmente nel 2013, i danni alle abitazioni sono stati ingenti, ma ormai recuperati. (A.F.)
 Non mancarono neppure, come, purtroppo, avviene sempre in queste momenti, episodi di sciacallaggio: la notte dell’8 settembre alcuni malviventi, infatti, tentarono di forzare la cassaforte della Cassa di Risparmio di Firenze, ma furono scoperti ed uno di loro, linciato da alcuni cittadini, morì. Si ha notizia pure di una evasione dal carcere mandamentale di Fivizzano: “Un individuo, arrestato per il furto dell’auto dell’ing. Mori, approfittò della caduta dell’ inferriata della cella a causa di una scossa e, calatosi con un lenzuolo, fuggì. Fu di nuovo arrestato dai carabinieri il giorno seguente a Gragnola, mentre tentava di derubare i feriti ricoverati sul treno ospedale”.
Non mancarono neppure, come, purtroppo, avviene sempre in queste momenti, episodi di sciacallaggio: la notte dell’8 settembre alcuni malviventi, infatti, tentarono di forzare la cassaforte della Cassa di Risparmio di Firenze, ma furono scoperti ed uno di loro, linciato da alcuni cittadini, morì. Si ha notizia pure di una evasione dal carcere mandamentale di Fivizzano: “Un individuo, arrestato per il furto dell’auto dell’ing. Mori, approfittò della caduta dell’ inferriata della cella a causa di una scossa e, calatosi con un lenzuolo, fuggì. Fu di nuovo arrestato dai carabinieri il giorno seguente a Gragnola, mentre tentava di derubare i feriti ricoverati sul treno ospedale”.
Ci fu anche chi cercò di lucrare sulle disgrazie di fivizzanesi che avevano subito danni alle loro abitazioni e che, progettando di trasferirsi altrove, accettavano qualsiasi somma per la loro vendita. La stragrande maggioranza della popolazione, però, si rimboccò le maniche e cominciò la ricostruzione, che completò in dieci anni.
Non fu certamente facile: il terremoto si era “presentato” all’indomani della Prima Guerra Mondiale e della “Spagnola”. I risultati non da tutti furono apprezzati, specialmente per quanto riguardava i palazzi storici, non sempre ricostruiti come gli originali, anche per disposizioni di legge, che, ad esempio, costrinsero ad abbassare di un piano gli edifici di piazza Medicea.
Ma la rovina e la morte, che si abbatterono principalmente su Fivizzano (è impressionante osservare i cumuli di macerie tramandati dalle fotografie), non risparmiarono altri paesi del Comune: vittime e distruzioni si contarono a Sassalbo e nelle varie frazioni, fino alla Valle del Lucido e del Bardine, per non dire della Garfagnana e delle altre zone della Lunigiana (a Pontremoli crollò il tetto della Chiesa della Misericordia), a dimostrazione, come ci racconta la storia, che la nostra è una “terra ballerina”.
Andreino Fabiani


