
Nel 2017 sono stati in totale 378 con 20 vere e proprie guerre ad elevata intensità. La produzione e il commercio di armi
 Nel corso del 2017 i conflitti nel mondo sono stati 378, tra cui la maggioranza dimenticati. Di questi, 20 sono guerre ad elevata intensità che coinvolgono 15 Paesi. Negli ultimi anni si è però verificato un decremento del 7,6% dei conflitti: erano 409 nel 2014. Eppure tra la popolazione italiana c’è una sorta di amnesia (o ignoranza?) piuttosto elevata sull’esistenza di tutte queste situazioni drammatiche.
Nel corso del 2017 i conflitti nel mondo sono stati 378, tra cui la maggioranza dimenticati. Di questi, 20 sono guerre ad elevata intensità che coinvolgono 15 Paesi. Negli ultimi anni si è però verificato un decremento del 7,6% dei conflitti: erano 409 nel 2014. Eppure tra la popolazione italiana c’è una sorta di amnesia (o ignoranza?) piuttosto elevata sull’esistenza di tutte queste situazioni drammatiche.
È quanto emerge dalla sesta edizione del rapporto di Caritas Italiana sui conflitti dimenticati nel mondo, pubblicata dal Mulino, con la collaborazione di Famiglia Cristiana, Avvenire e ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur).
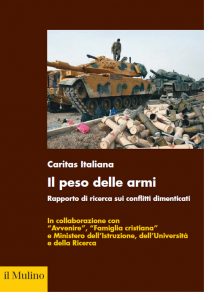 Il Rapporto è stato presentato a Roma, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. L’edizione 2018 è centrata sulla produzione e il commercio delle armi; il loro peso nel determinare i conflitti; il valore e il significato culturale delle armi nella nostra cultura, in particolare riguardo al mondo della comunicazione e della stampa; la consapevolezza di giovani e adulti.
Il Rapporto è stato presentato a Roma, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. L’edizione 2018 è centrata sulla produzione e il commercio delle armi; il loro peso nel determinare i conflitti; il valore e il significato culturale delle armi nella nostra cultura, in particolare riguardo al mondo della comunicazione e della stampa; la consapevolezza di giovani e adulti.
“Il numero di guerre ad elevata intensità nel 2017 non coincide con il numero di Paesi in guerra – precisa Walter Nanni, responsabile dell’Ufficio studi di Caritas italiana -, dato che presso uno stesso Paese possono essere presenti più fronti di guerra. Si pensi ai casi della Siria (3 diversi fronti di conflitto) e della Nigeria, Sud-Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Sudan (con due distinti fronti di guerra per ciascun Paese)”. Secondo il database dell’Heidelberg Institute tre guerre hanno visto un deciso incremento nel livello di violenza e conflittualità: Filippine e Myanmar e Corno d’Africa (Etiopia).
Aumentano, rispetto agli anni precedenti, i cambiamenti d’intensità di un conflitto in senso peggiorativo: nel corso del 2017 sono stati sette i conflitti che hanno conosciuto una escalation, trasformandosi in guerre ad alta intensità (quattro di questi nella sola Africa sub-sahariana).
Sono, invece, in calo quelle situazioni di conflitto che non sfociano in episodi di violenza armata: dal 2014 al 2017 tali fenomeni sono, infatti, diminuiti di 22 unità. Allo stesso modo, sono diminuite anche le “crisi non violente” e le “guerre limitate” (-8 situazioni, in entrambi i casi).
 Il volume riporta anche i risultati di un sondaggio demoscopico Swg sulla popolazione italiana. Metà degli intervistati (60% tra i giovani), sarebbe favorevole a limitare la produzione italiana di armi, evitando soprattutto di esportare armi laddove c’è guerra, mentre poco meno di un terzo ritiene che si tratti di un tipo di industria che andrebbe soppressa e riconvertita in altri tipi di produzione.
Il volume riporta anche i risultati di un sondaggio demoscopico Swg sulla popolazione italiana. Metà degli intervistati (60% tra i giovani), sarebbe favorevole a limitare la produzione italiana di armi, evitando soprattutto di esportare armi laddove c’è guerra, mentre poco meno di un terzo ritiene che si tratti di un tipo di industria che andrebbe soppressa e riconvertita in altri tipi di produzione.
Due terzi degli intervistati ridurrebbe anche la vendita di armi a persone o enti privati. Sul polo opposto, un segmento di popolazione, pari a poco più di un quinto, ritiene invece giusto produrre armi e lasciarne inalterata la vendita. Il livello generale di “amnesia” è, però, piuttosto elevato.
In riferimento agli ultimi 5 anni, il 14% del campione non ricorda neanche un attentato terroristico (10% tra i giovani). Il 24% degli italiani non ricorda neanche una guerra (29% dei giovani). Il conflitto più ricordato è quello siriano, col 52% del campione totale ma, ad eccezione della Libia, nessuna guerra del continente africano è ricordata da più del 3% degli intervistati.
Nel Rapporto sono poi riportati i risultati di un secondo studio condotto su un campione di 1.782 studenti di terza media inferiore, presso 45 istituti scolastici, in tutto il territorio nazionale. Il 39,3% dei ragazzi non è in grado di indicare neanche una guerra degli ultimi cinque anni.
Gli studenti che hanno invece fornito delle risposte “esatte” sono pari al 44,4% del campione. La metà degli intervistati ha dichiarato di conoscere la Dichiarazione universale dei diritti umani, di cui ricorre nel 2018 il 70° anniversario, mentre una quota importante di ragazzi, pari al 32,4%, non è sicuro di conoscerla. La grande maggioranza dei ragazzi considera la guerra come un “elemento evitabile”, da superare attraverso il progresso culturale.
Ma un ragazzo su cinque ritiene che la guerra è un elemento inevitabile, legato indissolubilmente alla natura dell’uomo. Per il 62,8% la guerra si previene mediante il dialogo e il rispetto dei diritti umani e intervenendo sui problemi economici e commerciali (51,9%).
Nel rapporto sono, infine, riportati i risultati di un terzo studio, condotto su un campione di ragazzi impegnati nello scoutismo: in media il 61,9% evidenzia un alto livello di sensibilità e di coerenza etica sui grandi temi della guerra e della pace, dell’accoglienza e della solidarietà (contro il 55%). Il 43,5% si dichiara favorevole ad accogliere nel nostro Paese, in modo incondizionato, i profughi e i richiedenti asilo (solo il 28,2% tra i ragazzi delle scuole medie in genere).


